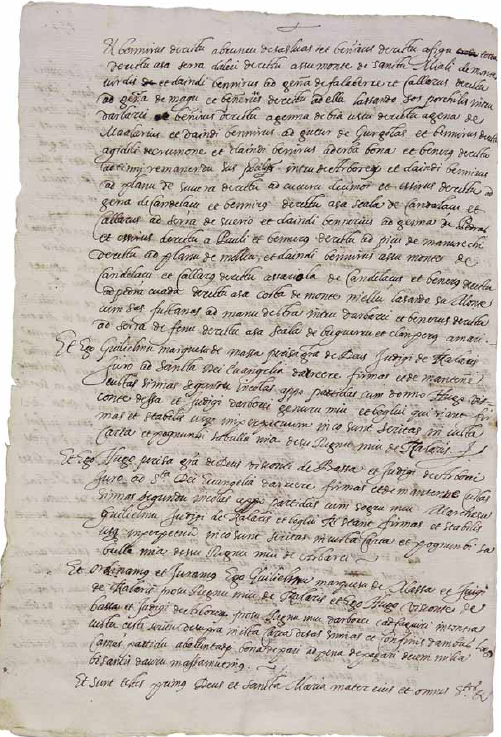Trattato di pace del 1206 tra il Giudicato di Cagliari e quello di
Arborea
di Sergio Sailis
Nel 1206 tra Guglielmo di Massa e
Ugo I di Bas-Serra di Arborea viene sottoscritto un accordo in base al quale
una parte del territorio arborense viene incorporato nel Giudicato di Cagliari
. In particolare, per la zona che ci interessa in questa sede, i confini tra i
due giudicati in questo documento vengono fissati qualche km più a nord di
Villamar nei pressi di ”Sancta Maria de Sinnas de Maara” da identificarsi con
la chiesa di Santa Maria di Monserrat nei pressi del Riu Mannu mentre secondo la “Donazione della Trexenta”
più o meno coeva (1218 o 1219 secondo lo stile pisano) passavano in prossimità
degli attuali limiti territoriali degli odierni comuni di Guasila e Villamar
appoggiandosi all’alveo del torrente Lanessi.
Da mettere in evidenza inoltre
che tra i testimoni oltre a vari vescovi isolani e vari altri personaggi sardi,
pisani e catalani sono presenti anche, tra i “liurus de Kalaris” diversi
notabili con interessi particolari e cariche di prestigio “quale per esempio
Curatore della Trexenta) che risultano attori o testimoni (quasi sempre
indicati con il titolo di Donnu) in numerosi documenti dello stesso periodo
editi dal Solmi tra le carte volgari dell’Archivio arcivescovile di Cagliari .
Il testo del trattato in esame è
il seguente:
In Nomine domini nostri Iesu
Christi, Amen.
Ego Guilielmu Marchesu de Massa,
per isa gratia de Deu Iudigi de Kalaris, clamandu-mi Iudigi Salusi, cun
boluntadi de Deus et de totu sus sanctos et sanctas Dei Amen, et cun boluntadi
de mugleri mia donna Guisiana et de figlias mias, donnigella Benedicta, et
donnigella Agnesa.
Et Ego Hugo per isa gratia de
Deus Visconte de Bassu et Iuigui de Arborea, cum boluntadi de Deus et de totu
sus sanctos et sanctas Dei Amen, et cum boluntadi de mugleri mia donna Preciosa
de Lacon, faguimus cartas impari de sas sinnas et confinis de Kalaris et de
Arborei. Repartirus inpari et segarus, Ego Guilielmu Marchesu de Massa et
Iudigui de Kalaris, et Ego Hugo Visconte de Bassu et Iudigui de Arborei, cum
boluntadi de sus Archiebiscobus et Piscobus et liurus d’ambus logus, po gi
stint impari et in beni ambus logus Kalaris et Arborei. Tenerus sinnos dava
Puçu d’Idalu et calarus cum sinnas derectu ad Oiastru Solus, et calarus deretu
a sa Corte dessa Pedra Recta in Monte Tufadu; ressit derectu a Tupa de Piga, et
calaus daretu a Pedras [.......] de Genna de Pirastru, et calaus daretu a Gutur
d’Argada, et calarus inuvi inter sa Binia et Nurechi, et calarus totui s’orroia
inter Su ’e Turri et Sancta Maria de Sinnas de Maara; et benerus inter muru de
Donnigallu et issa domestia de Baniu de Baressa ilassando-lla a manu destra
intru de Arbarei; et essit totui s’erriu derectu ad Sanctu Iorgi de Sinnas, et
bennirus totui s’erriu derectu assa Funtana de Sissoni, et benerus derectu ad
Cucuru de Stipoi, et calarus serra serra lassando ad manu destra s’erriu intru
de Arbarei, et calarus totui s’erriu s’erriu ad serras de Masoni de Iustu, et
calarus erriu erriu infini a sa bia ki baet dae Sellori et Sanctu Gavinu, et
uvi est sa Pedra Fita ki si clamat Pedra de Miliariu; et calarus sa bia sa bia
derectu a Giba de Onidi, et benirus derectu a Pedra Pertunta, et benirus deretu
ad Pedras de Regos, lasandu a manu destra intru de Arborei ad Pischina de Moiu,
et benirus derectu a su Bruncu de Bialana, et daindi benirus derectu a Giba de
Saraginus, et callarus derectu ad Orruina de Castula, et daindi callarus
s’orroia s’orroia de Funtana de Colora, et calarus derectu assa Bia de Pedras
de Fraus, et callarus a sa Bia dess’Arburi de Uvimali; et dainde callarus sa
bia sa bia de Fenuglei de Pedredu de Mau, et esirus derectu a sa Giba de sa
Ruina, et benirus derectu a Giba de Muteglu de Binias de Mau, et benirus serra
serra de Binias de Mau derectu a sa Genna de Saronai; et callarus derectu ad
Funtana d’Ebas, et bennirus derectu ad Genna de Scala, et daindi bennirus
derectu assa Sella de sa Pedra Alba et bennirus derectu a Bruncu de sas Luas,
et bennirus derectu a Figu Torta, derectu a sa Serra d’Aleci, derectu assu
monte de Sanctu Miali de Monte Virdis; et daindi bennirus ad Genna de Falaberxe,
et callarus derectu ad Genna de Magu, et bennerus derectu ad ella, lassando Sos
Porchilis intru d’Arbarei; et bennirus derectu a Genna de Bia Uscu, derectu a
Genna de Maalarius, et daindi bennirus ad Gutur de Gurgolas, et bennirus
derectu a Gidili de Crumone, et daindi benirus ad Erba Bona, et benerus derectu
ad Tinni, remanendu Sus Porcilis intru de Arborei, et daindi bennirus ad Planu
de Suvera derectu ad Cucuru de Simoi, et essirus derectu ad Genna de Candelaçu,
et bennirus derectu a sa Scala de Candalaçu, et callarus ad Serra de Suerio, et
daindi bennerus ad Genna de Pedras, et essirus derectu a Pauli, et bennerus
derectu ad Piçu de Manurechi, derectu ad Planu de Mollici, et daindi bennirus
assu Monte de Candelaçu, et callarus derectu ass’Ariola de Candelaçus, et
benerus derectu ad Pedra Cuada derectu a sa costa de Monte Niellu, lasando su
monte cum sas Funtanas ad manu destra intru d’Arbarei, et benerus derectu ad
Serra de Fenu derectu a sa Scala de Bugerru, et clonperus a mari.
Et Ego Guilielmu Marquesu de
Massa, per isa gratia de Deus Iudigi de Kalaris, iuro ad sancta Dei Evangelia
d’arreere firmas et de mantenne custas sinnas, segundu in co las appo partidas
cum donno Hugo Visconte de Bassu et Iudigi d’Arborei, genuru miu, et bogliu qui
siant firmas et stabilis usque im perpetuum in co sunt scritas in custa carta,
et pognu-ibi sa bulla mia de su Regnu miu de Kalaris.
Et Ego, Hugo, per isa gratia de
Deus Visconti de Bassu et Iudigi de Arborei, iuro ad sancta Dei Evangelia
d’arreere firmas et de mantenne custas sinnas, segundu in co las appo partidas
cum sogru miu Marchesu Guilielmu Iudigi de Kalaris, et bogliu ki siant firmas
et stabilis usque in perpetuum in co sunt scritas in custa carta, et pognu-ibi
sa bulla mia dessu Regnu miu de Arbarei.
Et ordinamus et iuramus, Ego
Guilielmu Marquesu de Massa et Iuigi de Kalaris pro su Regnu miu de Kalaris, et
Ego Hugo Visconte de Bassu et Iudigi de Arborei pro su Regnu miu d’Arborei,
c’ad faguiri incontra custu ç’esti scritu de supra in ista carta de sas sinnas
et confinis d’ambus logus c’amus partidu a boluntadi bona de pari ad pena de
pagari decem milia bisantis d’auru massamutinus.
Et sunt testes, primus Deus et
Sancta Maria mater eius et omnes sanctos et sanctas Dei, et donnu Riçu
archibiscobu de Kalaris, et donnu Bernardu archibiscobu d’Arborea, et donnu
Guantini piscubu de Oglia, et donnu Mariani piscubu de Sulçis, et donnu
Troodori piscubu de Suelli, et donnu Mariani piscubu de Terralba, et donnu
Bonacursu piscubu de Sancta Iusta, et donnu Mariani piscubu d’Usellos, et
Bonacursu de Gattu et Serranti de Pani e Porru, et Bonacursu Alferi et Romeri
Marcuchu, et Rana d’Agnellu et Simone Boco nobilis de sa civittadi de Pisas, et
Guilielmu de Sala, et Ramundu de Columbiera et Pier Iohan et Bernardo Bonamigu
et Guilfredi Beringeri, nobilis de Cadalonga; et liurus de Kalaris Mariani de
Çori Orlandu et Comida de Serra de Frailis, et Mariani de Unali Castai, et
Barusone de Serra Passagi, et Torbini de Lacunu Mancosu et Comida de Unali de
Genoni, et Barusoni d’Aceni, et Furadu Çurrunpis, et Ioanni de Serra Daluda et
Comida d’Arruu de Silvila, et Turbini de la Serra, et Goantini de Siillu et
Orçoco de Marognu, et Pedru d’Arcedi; et liurus d’Arbarei, Arçoco de Lacon
Sabiu et Gunnari su filiu, et Arçoco de Lacon Arbarichesu, et Barisone de Serra
su filiu, et Comida de Lacon Pees, et Comidai de Rana et Guntini de Martis.
Anno Domini Millesimo
ducentessimo sexto. Indictione nona, tercio kalendas Novembris.
Ego Ioannes quondam Guantini Pala
filius, auctoritate imperiali iudex ordinarius atque notarius et scriba
publicus Bandini Pedalis et Bernardi de Passa, consulum Pisanorum partis
Arestani, presentia, consensu, decreto et auctoritate de eorum consulum, hoc
exemplum scripsi et fideliter exemplavi de originali cuiusdam privilegii
auctentici sive bulle, nihil addens vel minuens quod sensum vel intellectum
mutet preter punctum litterarum seu silabam quod quidem exemplum diligenter
excultavi cum originali supradicto, cum infrascriptis notariis, videlicet
Nicolao quondam Alamanni Rubei a Pisis, Hubaldo de Greciano quondam Philippi de
Greciano et Simone filio Leonardi aurificis. Privilegium suprascriptum bullatum
erat cum duabus bullis plumbeis pendentibus cum cordellis de sirico viridi, in
una quarum erat scultus ex uno latere quidam miles [.....] annis super uno equo
cum spata in manu, scutu in brachio et elmo in capite, et erant ex dicto latere
hec littere, videlicet: Sigillum Ugonis vicecomitis de Bas, Iudicis Arboree; et
ex alio latere erat sculta quedam imago unius hominis sedentis super cathedra
ad modum regis, cum spata in una manu et corona in capite et in alia manu
lilium, et erant ex dicto latere iste similes littere. In alia vero bulla nulla
ymago sculta erat, nisi quod ex ambabus lateribus scripte erant littere grece.
Et quia sic deinceps exemplum de verbo adhibitum concordare inveni cum
originali predicti, me subscripsi et meum signum et nomen apposui. Actum in
Arestano [.......] Palati novi Archiepiscopatus Arborensis, presentibus
infrascriptis dominis Episcopis, Archipresbitero et Canonicis et notariis, et
domino Ganochiulo de Lanfrancis, domino Mariano de Plumbino iudice, domino
Falco Candido de Iuste, domino [...20...] de loco Arbaree, et domino Perastine
de Iana quondam domini Ioannis, testibus rogatis ad hec Dominice Incarnacionis
Anno Millesimo trecentesimo septimo. Indictione quarta, octavo idus Septembris.
Signum.
Per il testo dell'accordo cfr. Arrigo Solmi, Un nuovo documento per la storia di Guglielmo di Cagliari
e dell'Arborea, in Archivio Storico Sardo - vol. IV - fasc. 1/2 - anno 1908,
Cagliari 1908 e Eduardo BLASCO FERRER, Crestomazia sarda dei primi secoli -
vol. I, Officina linguistica anno IV - n. 4, Nuoro 2003, pag. 77